Baraa
A Abdul Masood, morto sulle coste del sud Bangladesh
A tutti i bambini che soffrono
A tutti i bambini del mondo
Nacqui con l’urlo più forte di mia madre.
Al tenero calore del ventre materno, subentrò una sensazione di ruvido della sabbia su cui caddi tra le gambe di mia madre, intorno a me il chiasso era forte e una strana luce disturbava i miei occhi non appena provavo ad aprirli. Due mani giganti e scabre mi alzarono da terra con cautela e i canti gioiosi delle donne che accompagnarono il distaccamento tra i corpi di madre e figlio vennero interrotti da mio padre che avvicinò le sue labbra al mio orecchio destro e intonó con voce carezzevole e commossa un dolce adan, un richiamo alla preghiera, “Allahu akbar, Allahu akbar”. Era armonioso, avrei voluto non finisse mai, “ashhadu alla Ilaha illa Allah”, si avvicinò accanto alla mamma che continuava all’unisono “ash-hadu Anna Muhammad rasulu Allah”. Tornai tra le braccia di mia madre , mi avvolse nel suo velo e mi strinse finché non sentii il battito del suo cuore, ricominciarono i canti delle donne, ero una nuova vita, una nuova speranza e mi chiamarono Baraa, innocenza.
Dopo 10 giorni dalla mia nascita imparai a osservare meglio il mondo che mi circondava. La mamma era scarna, a contatto con lei potevo sentire la durezza delle sue ossa; una lunga ferita rossa le percorreva il braccio destro, il suo sorriso era stanco come il suo gracile corpo, i suoi grandi occhi verdi si accendevano solo quando erano rivolti a me. Il freddo e la fame facevano di lei una scultura debole e affranta. La sera, prima di dormire, papà raccoglieva il mio corpo infreddolito tra le sue mani e mi recitava il corano, erano parole incomprensibili ma la sua voce ferma e celestiale accarezzava la mia pelle e innaffiava il mio cuore con nuova tranquillità; un sentimento di gioia cresceva dentro il mio animo e viaggiava in me donandomi sicurezza e pace. Era il momento che più amavo della giornata, volevo crescere e imparare anche io quelle parole divine così potenti.
16 giorni, ad un tratto implosero delle urla, una crescente confusione si diffondeva tra le persone attorno a me. Mamma mi strinse forte al petto e si mise a correre protetta da papà. Tutti si muovevano, un uomo senza una gamba venne aiutato da alcune persone a mobilitarsi, ci dirigemmo tutti verso la stessa direzione come uno sciame d’api diretto verso un campo fiorito. Il petto di mia madre tremava forte ma le sue mani restavano salde attorno a me. Un uomo urlava forsennatamente il nome di una donna, chiedeva di lei a chiunque, si batteva il corpo ripetendo lo stesso nome, a bassa voce mamma pronunciò “inna li Allah wa inna ilayhi raji’un”, siamo di Allah e a lui facciamo ritorno.
Camminavamo da due giorni, bisognava arrivare in un luogo sicuro dove nessuno poteva farci del male. Mi chiedevo il perché di questa sofferenza, cosa possedevamo di talmente prezioso da dover scappare e nasconderci per custodirlo, sarà forse la vita? Si pagava così il passaggio dal ventre materno a questo cumulo di macerie umane chiamato mondo? Il viaggio mi sfiancó, non ebbi più la forza nemmeno di piangere, mamma non riuscì più ad allattarmi e passavo le ore solo a giocare con il suo indice ossuto tra le mie mani. A volte ci fermavamo per del tempo in alcune zone ma poi, come dei reietti, ci veniva data la caccia e la nostra epopea ricominciava dall’inizio. Alcune notti le donne intonavano canti tradizionali, felici, in cui rendevano onore all’amore, alla gioia, al tempo che fu, alla vita e a tutto ciò che Allah ci ha donato e che l’uomo ha macchiato e corrotto. Era un modo per dimenticare la miseria che sopportavamo, per dare tregua alla fatica e alle lacrime.
Avevo 40 giorni quando arrivammo sulla costa. Sfinito mi sentii più solo come un cumulo di carne e ossa trasportato di zona in zona, di urlo in urlo, di fatica in fatica. Avevamo a disposizione alcune barchette per oltrepassare le acque, erano poche e bisognava prendere posto lasciando spazio agli altri, bisognava stare stretti come nel mondo. Mamma si accucció accanto a papà che mi teneva sulle ginocchia, mi coprirono con un velo per proteggermi dalla brezza fredda e salata. Il viaggio in mare cominciò, le onde trasportarono le nostre vite verso una meta sconosciuta e il mare ci promise un giorno in più da vivere. Vicino alle nuove coste la barca si rovesció, l’acqua mi accolse e fu come tornare nel ventre di mia madre; il freddo congeló ogni mia speranza, ogni mio sogno, le onde rubano il mio respiro, bevvi tutte le lacrime degli uomini sofferenti. Una mano mi afferrò per portarmi sulla terra ferma, mia madre posò le sue labbra bagnate da un pianto silenzioso e struggente sulle mie e mi strinse ancora una volta sul suo petto, immagino tremasse di nuovo. Un lontano “Allahu akbar, Allahu akbar ” eccheggió dentro di me e regalai l’ultimo respiro al vento.
Chissà se 40 giorni possono chiamarsi vita.
Nacqui con l’urlo più forte di mia madre. Morii conoscendo il suo pianto più doloroso.
Di Ikram El Mostachrik


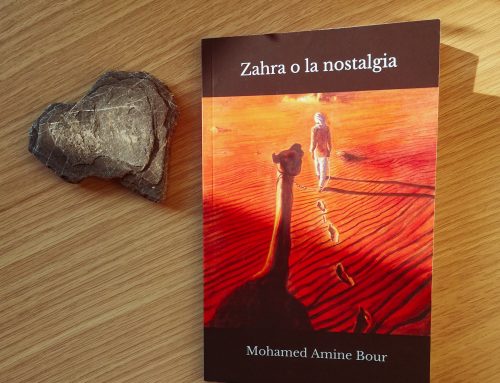



Leave A Comment